San Giuseppe d'Arimatea
La figura di Giuseppe di Arimatea emerge con forza nei Vangeli in occasione della sepoltura di Gesù. È un uomo ricco e onorato, un proprietario terriero, che fa parte del Sinedrio. Secondo Marco «anche lui aspettava il regno di Dio». È cioè un ebreo credente la cui fede nella speranza di Israele si traduce nella simpatia verso Gesù e nel dissenso da coloro che hanno favorito la condanna. Matteo va oltre affermando che era un discepolo del rabbi di Nazaret, Giovanni specifica «di nascosto per timore dei giudei».
Dopo la morte di Gesù, Giuseppe, primo tra i giudei, abbandona ogni precedente pusillanime esitazione per aderire apertamente alla fede cristiana. Ricorre, difatti, alla sua posizione altolocata per ottenere da Pilato il corpo di Gesù. Secondo le abitudini dei romani, invece, esso doveva essere seppellito in una fossa comune. Un gesto di coraggio e di generosità, perché la simpatia per il condannato poteva esporlo al rischio di essere considerato complice del giustiziato e passibile del medesimo supplizio. Inoltre, il contatto con un cadavere gli impediva di celebrare la Pasqua giudaica ormai imminente.
Aiutato da Nicodemo, che porta aromi in grande quantità, Giuseppe si distacca così dal sistema cultuale degli ebrei e si prepara alla celebrazione della gloriosa vittoria del crocifisso sulla morte in quello stesso giardino dove Gesù apparirà risorto alla Maddalena. Dopo la Pasqua non abbiamo più sue notizie dai Vangeli canonici, ma solo dagli scritti apocrifi. La sua figura è familiare all'immaginario dei credenti per la presenza nelle innumerevoli rappresentazioni della deposizione e sepoltura di Gesù.
Leggende
Durante il Medioevo, la figura di San Giuseppe di Arimatea assunse un ruolo centrale in due distinti gruppi di leggende che arricchirono l'immaginario collettivo dell'epoca. La prima di queste leggende lo ritraeva come il fondatore della cristianità britannica, mentre la seconda lo consacrava come il primo custode del Santo Graal. Queste narrazioni non solo plasmarono la percezione di Giuseppe di Arimatea, ma anche l'intero ciclo arturiano, una delle più influenti serie di racconti cavallereschi del Medioevo.
Giuseppe di Arimatea e il Santo Graal
Le leggende su Giuseppe di Arimatea e il Santo Graal emersero nel XII secolo, periodo in cui la letteratura medievale cominciò a esplorare e sviluppare la mitologia del Graal. La figura di Giuseppe fu inserita nel ciclo arturiano grazie all'opera di Robert de Boron, un poeta francese del tardo XII secolo, che nei suoi scritti gettò le basi di questa tradizione leggendaria. Nel suo lavoro intitolato Joseph d'Arimathie, Robert de Boron descrive un incontro mistico in cui Gesù appare a Giuseppe, affidandogli il compito di custodire il Graal, la sacra coppa utilizzata nell'Ultima Cena. Successivamente, Giuseppe e i suoi seguaci avrebbero intrapreso un viaggio in Britannia, portando con sé la preziosa reliquia.
Questa narrativa fu ulteriormente sviluppata in successive opere letterarie, dove si affermava che Giuseppe di Arimatea avesse non solo inviato i suoi seguaci in Britannia, ma che egli stesso vi si fosse recato, diventando il primo vescovo di quelle terre. Secondo queste leggende, Giuseppe avrebbe affidato il Santo Graal a suo cognato, noto come Hebron o "Re Pescatore". Quest'ultimo, a sua volta, lo avrebbe trasmesso ai suoi discendenti, ognuno dei quali avrebbe portato il titolo di custode del Graal, perpetuando così una linea di successione sacra.
Tuttavia, non tutte le vicende legate al Graal furono pacifiche. Una maledizione si abbatté infatti sulle terre del Re Pescatore, portando alla scomparsa del Graal e del castello in cui era custodito. Questa perdita segnò l'inizio di una delle più epiche quest narrative del ciclo arturiano: la ricerca del Santo Graal da parte dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Sotto la guida di Re Artù e su consiglio del saggio Merlino, i cavalieri si lanciarono in una missione per ritrovare il Graal, ma solo pochi tra loro si rivelarono degni di una tale impresa.
Lascia un pensiero a San Giuseppe d'Arimatea
Ti può interessare anche:

SacerdoteS. Giuseppe nacque a Copertino in Puglia nell'anno 1603 da pii genitori e prevenuto dall'amore di Dio, passò la sua infanzia in santa semplicità e purezza...

CappuccinoPrigioniero dei Turchi a Costantinopoli, fra Giuseppe era restato per tre giorni appeso a una croce per un piede e per una mano. E non era morto. Dio solo...
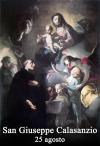
SacerdoteSi deve a Giuseppe Calasanzio la prima scuola popolare gratuita e aperta a tutti, a Roma. Calasanzio era il vicario generale della diocesi di Urgel, in...
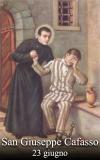
SacerdoteGiuseppe Cafasso, amico di san Giovanni Bosco, nacque a Castelnuovo d’Asti, un grosso borgo di campagna. Era il terzo di quattro figli in una famiglia...
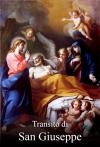
Patrono dei morenti e della Buona MorteTra i privilegi concessi a San Giuseppe, il più noto e celebrato è senza dubbio quello della sua pia morte. Secondo la tradizione, San Giuseppe...

SacerdoteGiuseppe Benedetto Cottolengo nacque nel 1786 a Bra, in Piemonte, primogenito di dodici figli di una famiglia borghese profondamente cristiana. La madre...
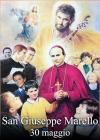
VescovoNato a Torino il 26 dicembre 1844, entrò nel seminario di Asti; fu ordinato sacerdote il 19 settembre 1868. Particolare amore pose nella formazione morale...
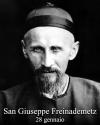
MissionarioGiuseppe nacque il 15 aprile 1852 nel piccolo villaggio di Ajes in Alto Adige. Il suo cognome significa, nel locale dialetto ladino "a metà strada sulla...
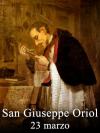
SacerdoteGiuseppe Oriol nacque da una povera famiglia di Barcellona il 23 novembre 1650. Il padre, Giovanni, tessitore di seta, morì sei mesi dopo la sua nascita...
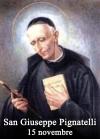
SacerdoteSan Giuseppe Pignatelli, sacerdote della Compagnia di Gesù, lavorò a Roma per migliorare le condizioni di questa famiglia religiosa che a quei tempi era...

SacerdoteNacque a Jalmolonga, Messico il 10 novembre 1851. Fu ordinato sacerdote i124 agosto 1879. Il 13 dicembre 1885, per curare i bambini abbandonati e poveri...
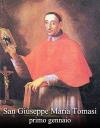
Cardinale, teatinoGiuseppe Maria Tomasi nacque a Licata in Sicilia il 12 settembre 1649. Era figlio del duca di Palma e principe di Lampedusa e della moglie Maria: avevano...

Sacerdote e martireGiuseppe Marchand nacque a Passavant in diocesi di Besangon nel 1803 e divenne membro della Società delle Missioni Estere di Parigi spinto dal desiderio...

VescovoNacque a Korczyna in Polonia, da studente prese la decisione di dare la sua vita al servizio di Dio, come lo esprimeva nel suo diario: "Gli ideali della...
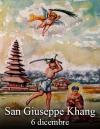
MartireNacque a Macao, in Cina, in una famiglia cristiana, trascorse la sua infanzia a Tra-Vi, nella provincia di Nam-Dinh, nel Tonchino. Doveva iniziare gli...
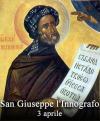
Monaco a CostantinopoliQuesta avvincente affermazione del papa ha il sostegno di numerosi pensatori, artisti e uomini di Chiesa, tra i quali Giuseppe l'innografo. Nacque in Sicilia...
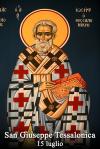
MartireGiuseppe nacque a Costantinopoli nel 760 circa; la madre era sorella di S. Platone (4 apr.), abate di Symbolès sul Monte Olimpo, esempio che persuase tutta...

Vescovo e martireGiuseppe Díaz Sanjurjo, nato nel 1818 a S, Eulalia de Suegos, nei pressi di Lugo (Spagna nord-occidentale), frequentò l'università di Compostella, divenne...

Arcivescovo di Lviv dei LatiniGiuseppe Bilczewski nacque il 26 aprile 1860 a Wilamowice, nell'odierna diocesi di Bielsko2ywiec. Il 6 luglio 1884 venne ordinato sacerdote. Divenne professore...

AbateIl monachesimo fu uno dei più larghi e fecondi movimenti religiosi, che producessero effetti di spirituale perfezione e insieme di civile progresso. Per questo la schiera dei Santi monaci è quasi sterminata...
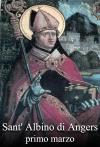
VescovoVescovo, santo vissuto tra il quinto e sesto secolo. Nato da una famiglia nobile, Albino diventò monaco in località Tincillac, situata probabilmente nella diocesi di Angers, dato che nel 529 fu eletto...

FondatoreAntonio Schwartz nacque il 28 febbraio 1852 a Baden (Austria), quarto di tredici figli; il padre svolgeva un servizio civile minore ed era musicista di teatro. Dopo la scuola elementare, Antonio diventò...

SacerdoteCarlo Gnocchi nasce a San Colombano al Lambro, vicino Lodi, il 25 ottobre 1902 da Enrico e Clementina Pasta, sarta. Ordinato sacerdote nel 1925 viene inviato prima a Cemusco sul Naviglio, poi nella popolosa...
I. O gloriosa S. Cunegonda, che tra gli agi della corte e lo splendore del trono non cercaste che la mortificazione dei vostri sensi e la felicità dei vostri sudditi, ottenete a noi tutti la grazia di...
I. Per quel miracoloso splendore e per quei suoni festivi onde il cielo illustrò la vostra nascita, o glorioso s. Giovanni, impetrate a noi tutti la grazia di mettere ogni nostra compiacenza nel...
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore vieni presto in mio aiuto. Preghiera O San Domenico Savio che nei fervori eucaristici estasiavi il tuo spirito...
O Dio Onnipotente ed Eterno, che in Santa Francesca Romana ci hai dato un modello di santità nella vita matrimoniale e nella conversione monastica, concedici, per sua intercessione, di conoscere...

 Condividi
Condividi






