San Filippo Smaldone
Filippo Smaldone nacque a Napoli il 27 luglio 1848, primogenito di una famiglia numerosa legata anche alla monarchia borbonica in un periodo di profonde trasformazioni politiche. Fin da ragazzo mostrò una grande sensibilità per i più poveri e un forte desiderio di consacrarsi a Dio. Entrato in seminario a Napoli nel 1863, la sua vocazione fu ostacolata da giudizi sull’insufficiente rendimento accademico, tanto che gli fu negata l’ammissione al clero locale. Decise allora di proseguire il cammino ecclesiastico nella diocesi di Rossano Calabro. Grazie al sostegno dell’arcivescovo Pietro Cilento, fu ordinato sacerdote il 23 settembre 1871, pur continuando ad accompagnare i poveri e i sordomuti già frequentati durante gli studi.
Alla sua ordinazione riservò molta attenzione all’insegnamento religioso e alla catechesi per i bambini sordomuti. Nella Pia Casa dei Sordomuti a Napoli, fece tesoro dell’esperienza acquisita con don Lorenzo Apicella, aprendosi a una concreta missione sociale, che lo portò anche a coinvolgersi in città come Salerno, Sorrento, Ischia e Amalfi.
Nel 1884, durante l’epidemia di colera a Napoli, Smaldone si ammalò gravemente ed è stato dato per morto. Si riprese miracolosamente, attribuendo la guarigione alla Madonna di Pompei, verso la quale coltivò una devozione duratura. Ripresosi, sentì impellente la necessità di istituire una nuova comunità religiosa dedicata all’educazione dei non udenti. Dalla fine del 1884 preparò tre giovani donne alla vita religiosa e il 25 marzo 1885 si trasferì a Lecce: lì nacque la prima Casa Madre delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, congregazione da lui fondata e dedicata all’istruzione, alla formazione morale e alla dignità dei sordomuti.
Nei decenni successivi, Smaldone ampliò la sua opera: vennero aperte nuove case a Bari, Roma, Salerno e altre località. Non solo per i sordi: molti istituti accolsero anche bambini ciechi, orfani e abbandonati, rispondendo a bisogni sociali emergenti. Accanto all’impegno educativo, il sacerdote coltivò un ministero spirituale intenso: fu confessore stimato per sacerdoti, seminaristi e comunità religiose, guidò la Lega Eucaristica dei Sacerdoti Adoratori e delle Dame Adoratrici, e fu superiore dei Missionari di san Francesco di Sales. Per le sue meritorie attività gli fu conferita la Croce Pro Ecclesia et Pontifice e gli fu riconosciuto il titolo di canonico della cattedrale di Lecce, oltre a una commendazione da autorità civili.
Negli ultimi anni soffrì gli effetti del diabete, aggravato da disturbi cardiaci e da un quadro di generale sclerosi. Morì serenamente a Lecce alle 21:00 del 4 giugno 1923, circondato dalle sue suore, sacerdoti e molte persone sordomute a cui aveva donato vicinanza e affetto. Da quel giorno la città salentina ha elevato un santuario in suo onore e ogni 4 giugno lo ricorda come memoria liturgica e spirituale.
La Chiesa riconobbe la sua santità con la beatificazione avvenuta il 12 maggio 1996 da Giovanni Paolo II, seguita dalla canonizzazione il 15 ottobre 2006 da Benedetto XVI in Piazza San Pietro. La sua vita di carità e la pedagogia dell’amore, che ha ispirato le Salesiane dei Sacri Cuori, restano un modello ancora vivente in diverse nazioni, dove la congregazione opera con passione in ambiti educativi e sociali rivolti ai non udenti.
Nel suo percorso spirituale e umano emerge un uomo che ha deciso di abbracciare una vocazione difficile con umiltà e tenacia, diventando “apostolo dei sordi” e testimone concreto dell’amore cristiano incarnato in impegno sociale, istruzione e compassione.
Lascia un pensiero a San Filippo Smaldone
Ti può interessare anche:
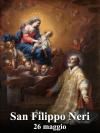
SacerdoteNacque a Firenze da ricca famiglia nel 1515. Ebbe un carattere singolarmente mite, così da essere chiamato "Pippo il Buono". Studiata umanità...
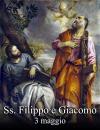
ApostoliS. Filippo, nativo di Betsaida, era un uomo giusto e spesso consultava le Scritture per conoscere quando si sarebbe avverata la promessa del futuro Liberatore...
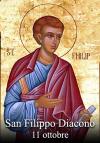
EvangelistaTutto ciò che sappiamo di Filippo Diacono è contenuto nella narrazione degli Atti degli Apostoli. Non è l'apostolo Filippo (3 mag.) ma uno dei diaconi...
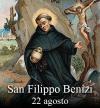
SacerdoteFilippo Benizi nacque a Firenze il 15 agosto 1233 da genitori che da tempo attendevano il dono di un figlio. Discendeva da due famiglie nobili: i Benizi...
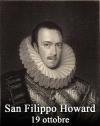
MartireFilippo Howard, figlio maggiore del quarto duca di Norfolk e rampollo della più importante famiglia aristocratica inglese, nacque a Londra nel 1557. Salita...

MartiriFilippo, vescovo di Eraclea, patì il martirio con il sacerdote Severo e il diacono Ermete durante la persecuzione dell'imperatore Diocleziano (284-305)...

AbateIl monachesimo fu uno dei più larghi e fecondi movimenti religiosi, che producessero effetti di spirituale perfezione e insieme di civile progresso. Per questo la schiera dei Santi monaci è quasi sterminata...
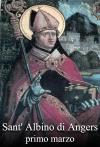
VescovoVescovo, santo vissuto tra il quinto e sesto secolo. Nato da una famiglia nobile, Albino diventò monaco in località Tincillac, situata probabilmente nella diocesi di Angers, dato che nel 529 fu eletto...

FondatoreAntonio Schwartz nacque il 28 febbraio 1852 a Baden (Austria), quarto di tredici figli; il padre svolgeva un servizio civile minore ed era musicista di teatro. Dopo la scuola elementare, Antonio diventò...

SacerdoteCarlo Gnocchi nasce a San Colombano al Lambro, vicino Lodi, il 25 ottobre 1902 da Enrico e Clementina Pasta, sarta. Ordinato sacerdote nel 1925 viene inviato prima a Cemusco sul Naviglio, poi nella popolosa...
I. O gloriosa S. Cunegonda, che tra gli agi della corte e lo splendore del trono non cercaste che la mortificazione dei vostri sensi e la felicità dei vostri sudditi, ottenete a noi tutti la grazia di...
I. Per quel miracoloso splendore e per quei suoni festivi onde il cielo illustrò la vostra nascita, o glorioso s. Giovanni, impetrate a noi tutti la grazia di mettere ogni nostra compiacenza nel...
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore vieni presto in mio aiuto. Preghiera O San Domenico Savio che nei fervori eucaristici estasiavi il tuo spirito...
O Dio Onnipotente ed Eterno, che in Santa Francesca Romana ci hai dato un modello di santità nella vita matrimoniale e nella conversione monastica, concedici, per sua intercessione, di conoscere...
- per espiare i peccati che...

 Condividi
Condividi






