Concattedrale di San Nicola
La Concattedrale dei Santi Nicola, Donato e Bonaventura sorge nella piazza centrale di Bagnoregio, nel cuore della Tuscia viterbese, in un luogo che affonda le sue radici nel cristianesimo delle origini. Eretta sul sito di una più antica chiesa dedicata a Santa Maria della Neve, la sua storia si lega profondamente ai mutamenti politici, religiosi e culturali dell’Alto Lazio.
Dopo il declino della vicina Civita, causato da un devastante terremoto nel 1695, papa Innocenzo XII trasferì ufficialmente la sede vescovile a Bagnoregio nel 1699. La collegiata di San Nicola, fondata nel XVI secolo, fu così elevata a cattedrale, arricchita dal titolo di San Donato e consacrata solennemente nel luglio del 1700.
Nel secolo successivo, sotto il vescovo Giovanni Carlo Aluffi e l’architetto Clemente Orlandi, la cattedrale subì un importante rifacimento che la trasformò nell’edificio attuale. La consacrazione definitiva avvenne nel 1779, con l’aggiunta del terzo titolare, San Bonaventura, nato proprio a Bagnoregio nel 1217.
Sulla facciata, rimodellata nel 1841, spiccano linee neoclassiche scandite da lesene e un frontone triangolare che la sovrasta, mentre accanto si eleva il campanile quadrato, alto circa 27 metri, la cui base incorpora antichi sarcofagi etruschi.
L’interno della Concattedrale è a navata unica, con tre cappelle laterali per lato, ornate da decorazioni in stucco e dipinti ottocenteschi. Gli affreschi furono realizzati tra il 1881 e il 1882 da Achille Monti e fra Silvestro dei Carmelitani Scalzi, che raffigurò sull’abside la Sacra Famiglia, i santi Nicola e Donato, e le vergini Vittoria e Teresa, mentre nei medaglioni trovano posto santi locali, tra cui Bernardo Janni e Sant’Ansano.
L’altare maggiore in marmi policromi domina la scena liturgica, mentre sotto l’arco trionfale è visibile un sarcofago romano del II secolo d.C., adattato a mensa liturgica secondo le norme post-conciliari.
Il Braccio Santo di San Bonaventura
Ma la presenza più preziosa e simbolicamente potente all’interno della Concattedrale è il Braccio Santo di San Bonaventura. Si tratta dell’unica reliquia rimasta del grande teologo francescano, dottore della Chiesa, dopo che gli Ugonotti, nel 1562, devastarono la sua tomba a Lione, disperdendo quasi completamente le sue spoglie.
L’unico frammento superstite è appunto il braccio destro, estratto solennemente il 14 marzo 1490 durante una ricognizione nella chiesa dei Francescani a Lione. L’anno successivo, il 1º maggio 1491, il prezioso arto fu donato a Bagnoregio dal vescovo di Vienne e dal Ministro Generale dell’Ordine francescano, Francesco Sansone.
Il braccio è custodito in un raffinato reliquiario d’argento dorato a forma di braccio benedicente, un capolavoro dell’oreficeria francese tardogotica. Questo oggetto non è soltanto una teca sacra: rappresenta un punto d’unione tra arte, teologia e devozione popolare. È conservato nella terza cappella a destra della navata, in un luogo silenzioso e raccolto, dove i fedeli possono sostare in preghiera.
La comunità di Bagnoregio ne ha fatto un simbolo identitario: il reliquiario fu infatti arricchito con oro e argento donati dalla popolazione nei secoli successivi al suo arrivo.
Ogni anno, il 14 marzo – data della traslazione – e soprattutto il 15 luglio – giorno della festa liturgica del santo –, la reliquia viene esposta solennemente e portata in processione per le vie del paese. La sera del 15, una suggestiva fiaccolata notturna attraversa le vie del borgo, con la sacra reliquia portata a spalla, tra preghiere, canti e commozione.
È un rito carico di significato, che lega il passato al presente e rinsalda il legame tra Bagnoregio e il suo figlio più illustre.
Nel 1986, con la soppressione della diocesi di Bagnoregio e l’unificazione alla diocesi di Viterbo, la chiesa perse il titolo di cattedrale per diventare concattedrale. Nonostante ciò, ha continuato a custodire con dignità la sua funzione liturgica e spirituale.
Dopo un cedimento strutturale del tetto nel 2011, l’edificio è stato restaurato e riaperto al culto nel 2014, restituendo alla comunità un luogo di grande valore religioso e culturale.
Lascia un pensiero su Concattedrale di San Nicola

Vescovo e martireCostanzo visse nel II secolo, era un giovane cristiano che si distingueva fin da subito nella Chiesa perugina per il suo zelo e per la sua generosità verso i poveri unita ad una grande severità verso se...

MartireQuesta santa Vergine romana discendeva da celebre famiglia consolare. Rimasta orfana ancora in tenera età, si dedicò con tutto l’ardore della sua anima giovanile alle opere della cristiana...
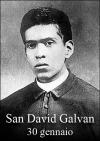
Martire MessicanoDavid nacque a Guadalajara (Jalisco, Messico). Era figlio di un operaio cristiano esemplare. Studiò alla scuola della Società Cattolica e nel 1895 entrò nel seminario di Guadalajara. Fu preso da una crisi...

Madre di famiglia e terziariaVillana, figlia del mercante fiorentino Andrea de' Botti, fuggì da casa a tredici anni per entrare in convento, ma suo padre riuscì a riprenderla e dopo qualche tempo la diede in sposa a Rosso di Piero...
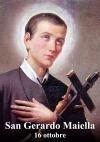
Religioso redentoristaGerardo era l'ultimo di 5 figli di una modestissima famiglia di Muro Lucano (Potenza) dov'era nato il 6 aprile 1726. Gente povera, i Maiella conducevano una vita al limite della sussistenza, tanto che...
Glorioso San Giovanni Bosco, che amaste con amore di predilezione l'angelica virtù della purezza e la inculcaste con l'esempio, con la parola, con gli scritti, fate che anche noi la diffondiamo con tutte...
1. Glorioso martire e nostro protettore S. Biagio, tu sin dalla fanciullezza sei stato sempre di esemplari virtù, e unendo alla sollecitudine pastorale di Vescovo l'arte della medicina, hai avuto modo...
I. O gloriosa s. Agata, che fino dai primi anni vi dedicaste interamente a Gesù Cristo con voto di perpetua verginità, otteneteci che almeno da questo momento ci consacriamo irrevocabilmente...
I. Per quella sì eroica obbedienza che voi esercitaste, o gran Vergine, nell'assoggettarvi alla legge della purificazione, ottenete anche a noi la più esatta obbedienza a tutti i comandi...
I. Ammirabile S. Geminiano, che poi vostro straordinario amore alla povertà, vi spogliaste ancor giovinetto del vostro patrimonio per darlo ai poveri, ed entrato nella clericale milizia, foste sempre così...
– O glorioso San Giovanni Bosco, per il grande amore con cui amasti la gioventù, della quale fosti Padre e Maestro e per gli eroici sacrifici che sostenesti per la sua salvezza, fa&rsquo...









